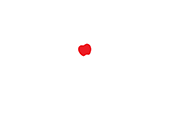El portava i scarp del tennis canta Enzo Jannacci. Portava le scarpe da tennis e – traduco dal milanese- parlava da solo. Inseguiva un sogno d’amore. Era il primo ad andarsene perché era un barbone. L’han trovato sotto un mucchio di cartoni, che sembrava un nessuno. Sembrava che dormisse. Lascia stare, che è roba da barboni.
Nel 1964, cioè in un altro tempo e in un altro mondo, andare in giro in scarpe da ginnastica era roba da barboni. Poco più di quarant’anni dopo, chi digita sneakers sul motore di ricerca Google trova milioni e milioni di evidenze. Un sacco di paia in vendita. Blog dedicati. Istruzioni per manutenzione e pulizia. Gloriosi siti istituzionali delle marche. Note allarmate sulle pericolose sostanze chimiche che alcuni produttori impiegherebbero. Sembra che, per presenza in rete, tra i capi d’abbigliamento, solo i jeans riescano a battere le sneakers.
Numeri molto, molto minori (cerco in inglese, per omogeneità), per magliette e abiti. Certo, anche in un passato recente, alcune distinzioni rilevanti in termini di identità di gruppo sono transitate per la scelta dell’uno o dell’altro modello di calzature: basti pensare ad anfibi e scarpe a punta, che negli anni Settanta costituivano parte non solo integrante ma sommamente discriminante dell’abbigliamento standard dei gruppi giovanili della sinistra e della destra. O al contrasto ugualmente forte che, pochi anni dopo, ha visto lo zoccolo femminista opporsi al tacco a stiletto.
Ma le scarpe da barboni sono qualcosa di più: un oggetto globale, e molteplicemente
globale, sia in termini di produzione, che di consumi, di immaginario e di desideri.
L’innamoramento è trasversale, interculturale, interclassista e intergenerazionale. Le distinzioni sono sottili ma, per gli adepti, tanto chiare quanto ferree: passano per la marca e il modello, il colore, il materiale, perfino l’anno di produzione.
C’è da chiedersi come sia successo tutto questo. La risposta possibile sta in una frase dello stilista Christian Lacroix, riportata da Naomi Klein nel forse troppo celebrato, ma sicuramente troppo presto dimenticato No logo (Baldini&Castoldi, Milano 2001): “È terribile da dirsi, ma molto spesso l’ispirazione per i capi d’abbigliamento più interessanti viene dalle persone più povere”.
E rieccoci al barbone. Anzi, al suo cugino nero, adolescente, afroamericano, che abita negli slum delle metropoli statunitensi agli inizi degli anni Novanta. Che gira in scarpe da ginnastica, preferibilmente senza lacci, secondo lo stile hip hop. E che è cool, cioè giusto, dritto, tosto.
Klein sostiene che le marche vendono ai giovani bianchi in base al loro fanatismo per lo stile dei neri, e ai giovani neri in base al loro fanatismo per il benessere dei bianchi. Il ragionamento sembra bislacco, ma chi sa un po’ di marketing (cioè della tecnica per orientare il consumatore verso il prodotto e il prodotto verso il consumatore, facendo in modo che l’incontro avvenga su un terreno favorevole per l’azienda) capisce che sta perfettamente in piedi. Sta di fatto che migliaia di cool hunters, di cacciatori di tendenze, oggi dragano le microculture giovanili che nascono alla periferia dell’impero e le segnalano alle marche e agli stilisti, che a loro volta le rielaborano e nel giro di una stagione le rilanciano sul mercato mondiale. E qui vale la pena di segnalare che anche la recente moda delle ciabatte infradito è nata così. E che, per tornare alle sneakers, da un paio d’anni le si vede tranquillamente indossate insieme allo smoking. Un’ultima nota: nel 1992 è uscito anche un film con Robert Redford e Mary McDonnell, intitolato Sneakers. È una pellicola cult per gli appassionati di informatica. Se cercate in Wikipedia potete leggere la trama, ma dovete digitare il titolo italiano: I signori della truffa.
Autore: Annamaria Testa
Consulente per la comunicazione
Anno: 2006/07